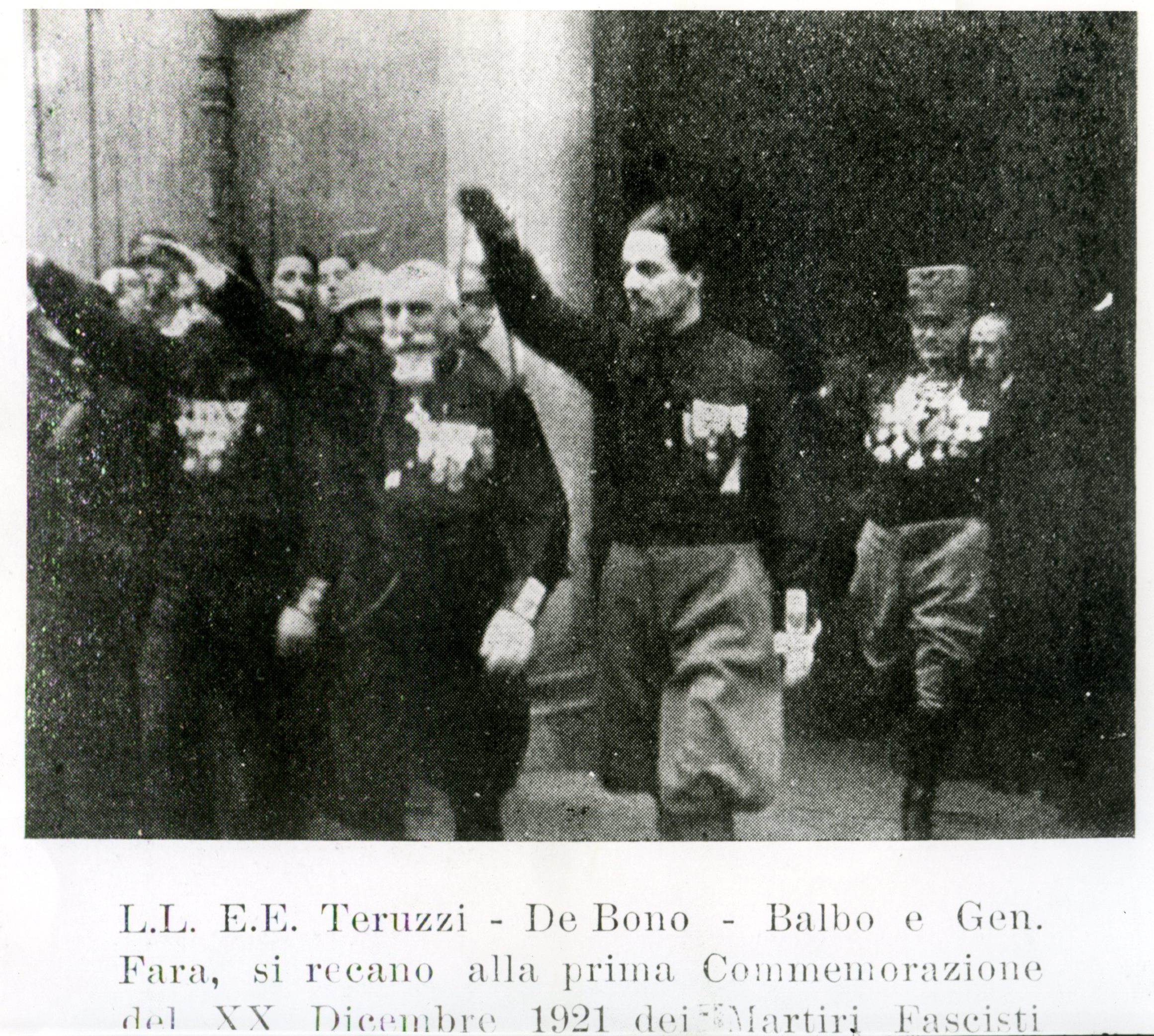LTornare a guardare alla situazione ferrarese dell’immediato dopoguerra non permette di distaccarsi dalla tradizionale distinzione tra un primo “biennio rosso”, grosso modo compreso tra il 1919 e il 1920, e un seguente “biennio nero” di reazione. Sono poche le realtà italiane dove si realizzò, al pari di quel che avvenne a Ferrara, un controllo altrettanto stretto della vita pubblica locale; così come è difficile rintracciare casi di un altrettanto rapido ribaltamento dei rapporti di forza, con l’azzeramento dell’influenza socialista e l’affermarsi del fascismo. Alla base del potere socialista, affermatosi con particolare vigore nell’immediato dopoguerra, v’era l’adesione delle popolazioni rurali del territorio, per lo più costituite da braccianti perennemente afflitti dallo spettro della disoccupazione, al sistema di lotta messo a punto dalle leghe di resistenza e dalle varie organizzazioni di classe
Poiché il vero nodo dei rapporti di produzione consisteva nella generale tendenza dei proprietari alla conduzione in economia, realizzata lucrando sulla miseria, sull’assoluta necessità dei braccianti di lavorare e sulla conseguente necessità di accettare salari da fame, il socialismo ferrarese crebbe quando dimostrò di sapere organizzare un’efficace resistenza, connotata da un’indispensabile radicalità, allo spadroneggiare dei ceti agrari. In altre parole, la venatura particolarmente accesa del socialismo ferrarese, in epoca giolittiana conquistato dalle idee e dalle pratiche del sindacalismo rivoluzionario, fu una diretta conseguenza della necessità di raggruppare i lavoratori all’interno di uno stesso campo: solo realizzando il monopolio del mercato del lavoro si sarebbero infatti potute imporre concessioni, sul piano salariale e lavorativo, all’agguerrito fronte padronale. La radicalità della contrapposizione sociale era dunque preesistente al cosiddetto “biennio rosso”: permeava la società rurale ferrarese, suggerendo i reciproci comportamenti tenuti dai contendenti. Su questa tela compromessa si sarebbe abbattuta la guerra, vissuta dalla grande maggioranza come una catastrofe imposta da pochi scalmanati interventisti; e poi giunse la Rivoluzione russa, con il suo immenso carico di attese millenaristiche. Non può quindi stupire lo stato di tensione che contraddistinse il primo biennio di pace; e non sorprende il fatto che la prassi di conduzione della lotta politica e sociale, da sempre caratterizzata dall’estremismo e dal rifiuto della mediazione, si sia allora improvvisamente trasfigurata in una sorta di scontro “finale”. L’estremismo di amministratori e capilega socialisti, con lo sguardo odierno difficili da giustificare, inevitabilmente additati ad esempio dell’inevitabilità della reazione padronale, s’inscriveva infatti in un canovaccio usuale, che si arricchiva ora di qualche sfumatura aggiuntiva di aggressivo rivoluzionarismo. E allo stesso modo bisogna intendere le lamentele di parte padronale, che si ripeterono in fondo sempre uguali a loro stesse. Così come nell’anteguerra queste ultime descrivevano la domanda di lavoro, trasformatasi da supplica a sciopero, come un’insopportabile lesione del diritto di proprietà; adesso quelle stesse lamentele, che incessantemente chiedevano l’intervento dello Stato, apparivano mosse dal desiderio di scaricarsi della responsabilità della gravissima crisi sociale esistente. A completare il quadro occorre infine ricordare la netta frattura tra l’ambiente rurale, contraddistinto dalla quasi totalitaria presenza bracciantile, e la città, tradizionale centro amministrativo vocato al soddisfacimento dei bisogni della rendita agraria. Se nella campagna il socialismo si configurò come l’armatura del proletariato, necessaria per affrontare i colpi scagliati dal padronato, nella città di Ferrara il notabilato liberale rimase sempre prevalente, forte dell’appoggio dei ceti commerciali e impiegatizi, nonché della numerosa e rumorosa gioventù universitaria. Non sorprende quindi che l’affermazione socialista, improvvisamente realizzatesi nell’immediato dopoguerra, sia stata dai ceti urbani interpretata come un’insopportabile lesione del naturale diritto di primazia. Anche da considerazioni come quelle appena accennate occorre avviare la riflessione, perché la realtà dell’annichilente violenza squadrista da sola non è sufficiente a spiegare la rapidità con cui il fascismo si trasformò in forza egemone nella provincia. Ma partiamo dall’inizio, tornando all’imponete dimensione dell’affermazione socialista nel dopoguerra. In occasione delle tornate elettorali, politiche e amministrative, il socialismo ferrarese, ottimamente organizzato da Gaetano Zirardini, ottenne infatti una sbalorditiva vittoria. Nel 1919 la lista socialista non solo guadagnò il 75,36% dei voti espressi nel collegio, con 6 deputati eletti su 8, ma registrò un consenso pressoché plebiscitario in quasi tutti i centri rurali della provincia (a Berra il risultato socialista superò il 95% dei voti espressi). Il successo fu confermato l’anno successivo, quando, in occasione delle elezioni amministrative, i voti socialisti doppiarono quelli dell’unione tra conservatori e popolari. Se nei seggi urbani la lista conservatrice ebbe la meglio (4.003 voti contro 3.723), nel forese la vittoria socialista prese l’aspetto di vera e propria valanga (10.185 voti contro 2.921). In qualche modo legittimata dai risultati ottenuti nei seggi, tra le due tornate la violenza politica espressa dai socialisti si dispiegò indisturbata, assumendo soprattutto l’aspetto dell’imposizione della volontà della massa organizzata su quella dei singoli. Da qui la stagione delle innumerevoli taglie inflitte dai capilega, anche per devianze minime o trascurabili mancanze, degli odiosi boicottaggi e dello stillicidio di piccole e grandi violenze (specialmente quelle compiute in primavera o in estate, quando cioè la vita agraria raggiungeva il momento di massima intensità). Da qui le vessazioni e le intimidazioni nei confronti delle poche amministrazioni rimaste nelle mani dei conservatori; come ad esempio a Massafiscaglia, dove, nel dicembre 1919, una folla di socialisti, pretendendo le immediate dimissioni del sindaco Giovanni Piva, invase tumultuante il Municipio. A fronte della resistenza dell’amministrazione, nei giorni successivi i capilega della zona imposero ai boari della famiglia Piva di lasciare incustodite le stalle. A quel punto il sindaco cedette e si dimise. La ricerca sulle fonti giornalistiche, integrate dall’esame della documentazione archivistica, ha permesso di ricostruire, attraverso la redazione di una dettagliata casistica, l’insieme di queste piccole e grandi angherie. Quasi sempre dettate dalla convinzione massimalista della necessità di ridurre tutti i lavoratori agricoli alla condizione bracciantile, queste azioni in realtà approfondivano le fratture interne alla società rurale ferrarese. A dispetto dell’apparente unanimità, risultato soprattutto della grande forza d’intimidazione espressa dall’organizzazione socialista, il mondo contadino rimaneva infatti estraneo all’ideologica visione massimalista della futura organizzazione sociale ed economica. A rifiutarla non erano solo gli affittuari e i coloni, nonché i tanti piccoli e piccolissimi proprietari creati dal grande fenomeno di vendita delle terre, ma anche gli stessi braccianti obbligati, che nutrivano forti perplessità rispetto all’idea di diventare semplici avventizi (cioè, lavoratori contrattualmente privi di qualsiasi tutela; dunque, totalmente dipendenti dall’avveramento dei sogni di rivoluzione sociale). Il vero problema era però un altro: a causa delle condizioni strutturali dell’economia agraria ferrarese non poteva affermarsi alcuna politica di mediazione tra le parti; ma stando così le cose ogni cedimento, anche di minimo valore, era interpretato come un pericolosissimo precedente, in grado di innescare una rapida spirale involutiva, che, nutrendosi della disaffezione dei militanti, avrebbe inevitabilmente condotto alla completa sconfitta. Insomma, la corsa non sembrava consentire decelerazioni. Da qui la contraddizione, lucidamente messa in luce da Alda Costa. In un articolo apparso su Scintilla (31 luglio 1920), l’anziana leader del socialismo ferrarese mise in guardia i compagni di partito: a fronte del clima complessivo, pronto ormai per uno scatenamento rivoluzionario delle masse, la passività dei vertici del partito, che a parole approvavano ma sotterraneamente frenavano, rischiava di fare perdere ogni fiducia nella risolutezza socialista; e se ciò fosse accaduto, allora le masse si sarebbero ritrovate in balia della reazione. Si trattò di un vaticinio drammaticamente esatto, perché la reazione fascista era ormai alle porte e pronta a scatenarsi. Esattamente come stava avvenendo a Bologna, anche a Ferrara il fascismo fu inizialmente cittadino; e allo stesso modo che nel capoluogo felsineo, anche nella città estense il primo nucleo della reazione fu costituito da ex combattenti, giovanissimi studenti, nazionalisti ed elementi che avevano precedentemente militato nelle formazioni del patriottismo antitedesco del tempo di guerra. Già nel corso dell’estate del 1920, in coincidenza con il momento di maggior e intensità delle otte agrarie, questi elementi iniziarono a presentarsi sulla scena pubblica, rendendosi protagonisti di zuffe, provocazioni e bastonature. Per l’esiguità numerica rispetto alle masse socialiste, in un primo momento queste attività non uscirono dal perimetro cittadino, assumendo l’aspetto tipico dell’ardimentosa prova di coraggio del singolo contro la massa. La rivelazione dell’esistenza di un’alternativa alla forza pubblica, alle istituzioni che parevano immobilizzate, fu improvvisa. Esattamente come era avvenuto a Bologna, il giorno dell’insediamento della giunta comunale di Ferrara – 20 luglio 1920 – i fascisti provocarono tafferugli, che si conclusero in una strage. Esattamente come era avvenuto a Bologna, l’eccidio ebbe un effetto rinvigorente della reazione antisocialista. Non solo funzionò da chiamata a raccolta delle forze patriottiche e antisovversive, ma fornì al fascismo, in virtù di una lettura degli eventi tutta interamente orientata alla criminalizzazione dei socialisti, una straordinaria patente di legittimità. Qualche settimana dopo la nomina a capo del fascismo ferrarese di Italo Balbo, ex ufficiale e personalità particolarmente dotata dal punto di visto organizzativo, avrebbe sancito la definitiva saldatura tra quest’ultimo e la grande proprietà agraria. Da questo momento gli eventi si accavallano, con un’accelerazione determinata dall’abilità fascista nell’aggredire il socialismo locale, nelle persone e nelle cose; tanto che nel giro di pochi mesi si sarebbe determinato il completo collasso dell’organizzazione socialista ferrarese. La ricerca compiuta sulle fonti permette di evidenziare l’importanza della violenza, quale fattore determinante del crollo socialista e della parallela affermazione, piena e totale, del fascismo. L’elenco delle azioni compiute dagli squadristi è del resto impressionante; soprattutto, la sua lettura permette di ridimensionare l’apporto memoriale offerto dalla cronachistica fascista, smentendo la validità delle narrazioni squadriste e contestando il topos della supposta cavalleria dei fascisti (che avrebbero sempre e soltanto reagito alle provocazioni dei “rossi”). Dalla lettura dei dati scaturisce un quadro molto più fosco rispetto al conosciuto, intessuto di uccisioni e di brutali bastonature; una realtà di dolore, capace di devastare il senso di identità delle comunità locali e riorganizzarne le gerarchie sociali. Attraverso l’analisi delle notizie presenti sui giornali diviene possibile osservare il dispiegarsi di una chiara strategia di conquista, incardinata sull’uso di una ferocia estrema, che annichilisce ogni capacità di resistenza e destruttura tutti i punti di riferimento delle comunità locali; fino all’esito finale, con il passaggio degli uomini e delle relazioni sociali all’ombra della protezione offerta dallo stesso fascismo. Si trattava di una strategia ambiziosa, che ebbe tanto successo solo perché poté avvalersi dei gravi errori compiuti dalla dirigenza socialista. In preda alla confusione, incapace di elaborare azioni che non fossero aggressive minacce o lamentose richieste di aiuto, quest’ultima si rifugiò infatti nella più totale passività. Il risultato fu devastante: non solo le forze dell’ordine si mantennero fedeli all’atteggiamento smaccatamente filofascista, ma si determinò un’accelerazione nel processo di smobilitazione della militanza socialista. A dispetto della promessa di un prossimo frazionamento dei latifondi, a cui i braccianti ferraresi probabilmente non credettero mai, la scelta di passare armi e bagagli alle organizzazioni fasciste fu dettata dalla sola considerazione d’utilità: all’indomani della distruzione delle organizzazioni di classe, a dispetto del ritorno a Ferrara di una personalità come quella di Edmondo Rossoni, la creda realtà era che non esisteva alcuna possibilità di sopravvivenza all’esterno del perimetro tracciato dal fascismo. Anche se la vita sarebbe stata più dura e stentata, l’adesione al sindacato autonomo rappresentava l’unica possibilità di sopravvivenza sopravvissuta. Accanto alla violenza, brutale e spietata, espressa con un livello di intensità senza apri, un elemento cruciale dell’esperienza fascista a Ferrara fu il precoce riconoscimento della spettacolarità dell’azione quale connotato essenziale della politica moderna. Attraverso i cortei e le sfilate militari, accolte dal lancio dei fiori e dallo sventolio delle bandiere tricolori, si realizzò – come notò Sergio Panunzio – la conquista psicologica delle masse al fascismo. Si può certo dubitare dell’adesione spontanea, specie nei comuni rurali fino a pochi mesi prima organizzati su altre idealità e valori, ma non si può minimizzare sull’importanza che tali riti di conquista ebbero per consolidare la percezione dell’inevitabilità della vittoria fascista e dell’insensatezza dell’opposizione. La città dello squadrismo, Ferrara avrebbe conservato a lungo, per almeno una ventina d’anni, la sua triste e non usurpata fama.